In Iraq si muore, a Roma si fa accademia
Mentre quotidianamente arrivano dall'Iraq gli appelli dei vescovi locali e dei patriarchi orientali per un intervento armato immediato per scongiurare l'eliminazione dei cristiani, da noi si prende a pretesto il Papa per giustificare l'inazione. E si attacca chi ha il coraggio di chiamare i terroristi con il loro nome.
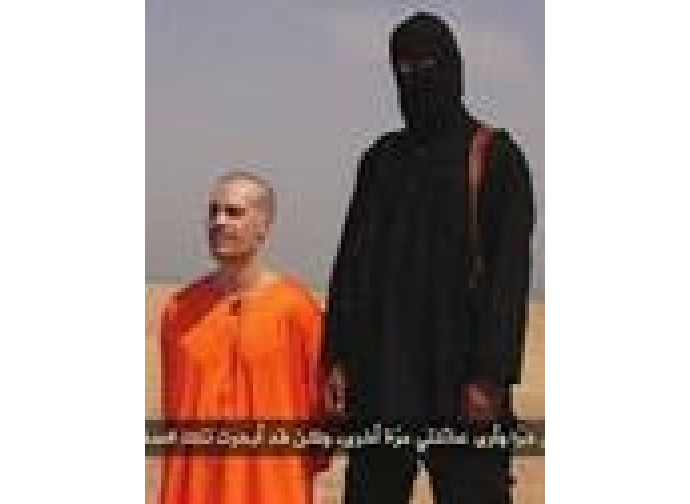
In Iraq si muore, a Roma (e non solo) si fa accademia. È un po’ questa l’impressione che si ricava mettendo a confronto i drammatici appelli che quotidianamente arrivano dai vescovi del Medio Oriente e le incredibili divagazioni sul tema che leggiamo sulla stampa nostrana, spesso ad opera di uomini di Chiesa.
Da Erbil, la città curda dove trovano riparo la maggior parte dei cristiani scacciati da Mosul e dalla piana di Ninive, si sono fatti sentire ieri, ad esempio, i patriarchi orientali cattolici e ortodossi andati lì per portare la propria solidarietà ai cristiani. «Noi lanciamo un grido d'allarme - ha spiegato il Patriarca Youssef II Younane, dei siro-cattolici - Non c'è nemmeno un secondo da perdere. È in gioco la nostra sopravvivenza in Mesopotamia. Le nazioni libere che aderiscono alla Carta dei diritti dell'uomo devono avere il coraggio di essere fedeli ai loro principi. Noi chiediamo un intervento internazionale in nostra difesa, e non certo per conquistare alcunché. Noi abbiamo il diritto di difenderci e noi chiediamo di essere difesi. La comunità internazionale lo ha ben fatto in precedenza in Kosovo, malgrado l'opposizione, all'epoca, della Russia. Per questo noi domandiamo, assieme a Papa Francesco, di fare in modo che vengano rispettati i nostri diritti per un intervento militare di natura difensiva, per fronteggiare i gruppi jihadisti che ci minacciano».
«Noi pensiamo – ha inoltre detto il patriarca maronita Bechira Rai - che lasciare campo libero agli jihadisti dello Stato islamico sarebbe davvero vergognoso per l'Occidente. Che un gruppo di terroristi di ispirazione diabolica sia lasciato libero di agire è uno scandalo senza precedenti. Noi chiediamo alla comunità internazionale di assumersi le proprie responsabilità. È inammissibile che un gruppo di questa natura opprima in questo modo dei popoli, e che la comunità internazionale non prenda la difesa di un gruppo incapace di difendersi da solo».
Parole chiare, analoghe nei contenuti e nel tono, a quelle sentite in queste settimane dai diversi vescovi iracheni: è richiesto un intervento urgente; e armato, perché i terroristi dell’ISIS non si fermano a belle parole.
A Roma invece si continua a discutere sul significato da attribuire alle parole del Papa sul «fermare gli aggressori», e come quindi si può fermarli senza usare le armi, non sia mai che vogliamo le Crociate o solo contrapporre la forza alla forza.
Il Papa fa bene a ricordare i criteri fondamentali che guidano anche un intervento militare difensivo, è la dottrina della Chiesa da sempre, e non sta a lui indicare soluzioni politiche o militari. Ma i laici e coloro che sono chiamati a prendere decisioni o a suggerirle, devono dare contenuti seri a questi criteri, non possono fare omelie sulle parole del Papa riservando al contempo la loro aggressività nei confronti di tutti coloro che chiamano i terroristi con il loro nome e che invocano un intervento serio.
Chi sta facendo la guerra ad Antonio Socci – reo di aver criticato la tiepidezza del Papa – dovrebbe avere il coraggio di andare fino in fondo e criticare tutti i vescovi iracheni e i patriarchi orientali che chiedono di intervenire urgentemente, e possibilmente non a chiacchiere. Socci sarà pure criticabile, ma non è lui che sta sgozzando ostaggi e dando la caccia a cristiani e yazidi. E non siamo noi - che insistiamo nel denunciare la minaccia islamista - quelli che hanno dichiarato guerra agli infedeli, la Terza guerra mondiale tanto per citare il Papa. Chissà se poeti, intellettuali e preti che gridano dappertutto che non c’è bisogno di Crociate sarebbero così compassati e meditabondi sulle parole del Papa se ad essere stuprate e usate come bottino di guerra fossero le loro figlie e mogli e se ad essere sgozzati in nome di Allah fossero i loro figli.
Noi non vogliamo dichiarare guerra a tutti i musulmani, ci mancherebbe altro. O affermare che tutti i musulmani sono potenziali terroristi. Al contrario, vogliamo valorizzare tutto quello che di positivo si muove nel mondo islamico. Ma allo stesso tempo non si può chiudere gli occhi davanti a quel che sta accadendo e, in ogni caso, prima ancora di discettare sui princìpi dell’islam, occorre «fermare l’aggressore». E bisogna essere concreti: se non si vuole fare una guerra, in quale altro modo si possono fermare questi barbari?
Non si può giocare con le parole, come fa ad esempio, il segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, monsignor Mario Toso. In una intervista a Radio Vaticana, commentando le parole del Papa, ha detto ieri che si deve rinunciare «definitivamente all’idea di ricercare la giustizia mediante il ricorso alla guerra». Bene, e allora cosa facciamo davanti all’Isis? «Occorre - dice Toso - imboccare vie alternative: va cioè coltivata la multilateralità come via che offre maggiori garanzie di giustizia, anche nel caso che si debba attuare il principio di responsabilità di proteggere etnie e gruppi che sono minacciati di morte, come sta avvenendo in Iraq, da gruppi terroristici». E cosa vuol dire? La multilateralità non è una risposta al «cosa facciamo», al massimo è un metodo. E il resto sembrano frasi fatte, senza un senso vero, tanto per dare l’idea di dire qualcosa di profondo.
Ma cominciamo a vedere seriamente quali sono le alternative: i paesi occidentali, tutti d’accordo, si stanno muovendo per armare i curdi e dare loro la possibilità di difendersi. Va bene questo per i nostri amici che non vogliono Crociate? Non suona un po’ ipocrita e vagamente vigliacca come soluzione? Noi non vogliamo la guerra, ma vi diamo le armi per farla. Così abbiamo un doppio guadagno: non ci rimettiamo vite umane e ci facciamo i soldi con la vendita delle armi. Dare la possibilità a chi è attaccato di difendersi è giusto, ma fatta in questo modo non suona certo come un impegno. E senza considerare che anche questa via ha le sue controindicazioni: si incrementa la proliferazione di armi, anche pesanti, che in giro per Medio Oriente e Africa sono già troppe, e si aprono futuri contenziosi visto che i curdi ora si aspettano come ricompensa la creazione e il riconoscimento del loro stato, il Kurdistan.
La scorsa settimana, il nunzio apostolico all’Onu di Ginevra, monsignor Silvano Tomasi, aveva anche suggerito di bloccare il flusso di fondi e armi verso i miliziani dell’Isis. Più che giusto, ma anche questa non è una strada facile, immediata e risolutiva: ormai gli jihadisti hanno trovato il modo di autofinanziarsi – i rapimenti di occidentali servono a questo – e comunque c’è una pressione forte da fare sui paesi – Arabia Saudita, Qatar, Kuwait – da cui passano gran parte dei rifornimenti per l’Isis. E nessuno in questo momento sembra neanche pensare a questa strada, non ultimo perché anche in Europa siamo dipendenti dagli investimenti di questi paesi.
Dunque, quali sarebbero le altre alternative immediate a un intervento militare? Sicuramente ce ne saranno anche se in questo momento non ci vengono in mente, ma invece di meditare profondamente sulle parole del Papa, le si prenda sul serio e si formulino ipotesi concrete. Ad esempio, si prendano per la collottola i nostri governanti, molto più interessati a discutere del patetico topless di una ministra ultracinquantenne che non ad affrontare la minaccia jihadista che arriva da noi anche in barca (e li andiamo pure a prendere).
Soprattutto si risponda a questa domanda: e se le Nazioni Unite non avessero alcuna intenzione di muoversi, come peraltro appare evidente al momento (quante riunioni d’urgenza del Consiglio di sicurezza sono state convocate per discutere del Califfato?), che cosa si fa? Ce la sentiamo di abbandonare i fratelli cristiani iracheni - e mediorientali in genere - al loro destino, consolandoci con il fatto che tanto la persecuzione è nel nostro Dna?
