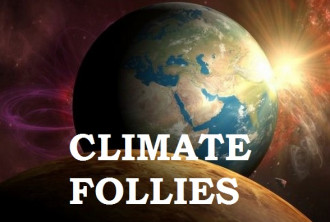Rupnik, la realtà e il diritto al "buon nome"
L'assurdità della lettera dello scorso 26 febbraio del Dicastero per l'interpretazione dei Testi Legislativi in cui ci si preoccupa del "buon nome" e della "denigrazione" dei sacerdoti, emerge con i nuovi particolari dello scandalo Rupnik. È ora di un cambiamento.

Pubblichiamo la traduzione dell'articolo di John M. Grondelski apparso il 4 marzo su New Oxford Review a commento del reportage della Bussola sulla presenza di padre Marko Rupnik a Montefiolo (Rieti).
Il sito web italiano La Nuova Bussola Quotidiana ha pubblicato il 3 marzo una notizia secondo cui Marko Rupnik e i suoi confratelli del Centro Aletti si stanno trasferendo in un convento a Montefiolo, a nord-est di Roma. Secondo la notizia, le suore che attualmente si trovano lì sono state sfrattate. Il sito sostiene che l'intera procedura gode molto probabilmente dell'appoggio del cardinale Angelo De Donatis, già Vicario Generale di Roma (il delegato del Papa nella gestione la sua diocesi) e ora Penitenziere Maggiore (il cardinale che dirige il lavoro del “foro interno” della Chiesa, cioè l'amministrazione del sacramento della Penitenza). Molti considerano De Donatis come protettore di lunga data di Rupnik.
Rupnik, abusatore ma pupillo del papa, è riuscito a lungo a eludere le sanzioni per il reato canonico di aver assolto un complice in un peccato contro il sesto comandamento. I gesuiti sono riusciti a lavarsene le mani, espellendolo per disobbedienza (un po' come quando si viene cacciati dalla Chiesa anglicana per eresia). L’ormai libero Rupnik si è poi fatto incardinare in una diocesi slovena, con l'intesa che non avrebbe mai dovuto esercitarvi il ministero. (Immaginate quanto andreste lontano con un vescovo americano, qualora gli diceste che vorreste servire il popolo di Dio in un college o in un'università, piuttosto che in una parrocchia!).
Nessuno si aspettava che vivesse in Slovenia, ma ora sembra che abbia ottenuto una sistemazione in cima al monte, non troppo ma sufficientemente lontana da Roma per continuare gli affari in stile Aletti, a quanto pare con la condiscendenza di un cardinale protettore. Nel frattempo, il Dicastero per la Dottrina della Fede (in base a norme riviste che esentano il suo Prefetto, un altro pupillo del papa, dal lavoro disciplinare) continua la sua indagine che, se prolungata, potrebbe ancora una volta produrre il magico “effetto McCarrick”: tutti quelli che sapevano qualcosa sono morti e quelli vivi non sapevano nulla! I vaticanisti riferiscono che il “falso misticismo” di Rupnik non è, a quanto pare, un'accusa sufficientemente chiara per una punizione canonica; solo i canonisti possono cavillare se un sacerdote, membro di un ordine religioso che un tempo era considerato le truppe d'assalto intellettuali e i marines spirituali del papato, che ha convinto una suora a un rapporto sessuale come esperienza spirituale mistica, possa essere abbastanza penalmente peccaminoso da essere sanzionato.
Sollevo tutti questi elementi alla luce di una lettera pubblicata il 26 febbraio dal Dicastero per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, sulla “buona fama” dei sacerdoti predatori sessuali “credibilmente accusati”, specialmente quelli morti. Con la consueta “trasparenza” vaticana, il destinatario della lettera non è specificato, né si spiega perché il documento scritto il 5 settembre 2024 abbia improvvisamente visto la luce quasi mezzo anno dopo. Far parte della Curia romana di Francesco significa non dover mai dare spiegazioni.
Può essere che sia una coincidenza che la lettera sia uscita proprio quando è emersa la nuova storia di Rupnik. Ma il punto è un altro: dovremmo forse mettere in discussione le argomentazioni della lettera?
Tracciamo alcune chiare linee metodologiche. Questa lettera è un documento giuridico, una risposta a una richiesta legale su ciò che le disposizioni del Codice di Diritto Canonico richiedono in questi casi. In quanto tale, si tratta di un'interpretazione di una legge positiva e almeno teoricamente distinta dalle questioni morali che implica riguardo al buon nome, alla denigrazione, alla calunnia e alla trasparenza. Se debba essere così distinta è un'altra questione, ma questo pontificato ha avuto la tendenza di brandire la clava del diritto canonico come arma e scudo, indipendentemente da quanto bene o male la legge si ponga a servizio della buona teologia. Il diritto canonico dovrebbe essere radicato nella buona teologia e servirla; se lo abbia fatto, soprattutto negli ultimi anni, è un’altra questione.
Scrivo come teologo morale e ammetto che sto ricercando la logica che sta dietro a ciò che la Chiesa insegna sulla buona fama, la denigrazione e la calunnia. Lo faccio proprio perché penso che troppi ecclesiastici, inclusi troppi appartenenti alla gerarchia, si siano rifugiati dietro la “denigrazione” e la “buona fama” per giustificare sia la loro negligenza sia la copertura di sacerdoti predatori sessuali, soprattutto omosessuali.
La Santa Sede ha avuto la tendenza a fare il bello e il cattivo tempo per quanto riguarda lo sradicamento degli abusi sessuali del clero. Le accuse pubbliche di abuso vengono accolte con critiche di “denigrazione” e con la necessità di “preservare il buon nome” dell'accusato. Queste critiche, ovviamente, non affrontano il motivo per cui le persone si rendono pubbliche, e cioè perché non si fidano del clero della Chiesa per condurre un giudizio tempestivo ed equo in un contesto chiuso e riservato. E, visto lo stillicidio di casi di abusi sessuali che ha colpito la Chiesa a partire da Boston 2002, e soprattutto dopo l'affare McCarrick, nessun uomo onesto dovrebbe biasimare queste persone per la loro mancanza di fiducia.
La lettera del Dicastero sembra provenire da un mondo immaginario in cui (1) non sono accaduti né Boston 2002, né l'affare McCarrick, né i diffusi procedimenti civili negli Stati Uniti, in Canada, in Irlanda, in Germania, in Australia e in Francia; (2) non si può far finta che i social-media laici che riportano le accuse di abusi sessuali non esistano e non siano stati di solito la prima causa di smascheramento di questo marciume peccaminoso; (3) i cattolici sospenderanno generosamente il giudizio in attesa di “prove giudiziarie contrarie e definitive” (vale a dire, presumibilmente un verdetto finale e inappellabile); e (4) la credibilità della Chiesa stessa non è in gioco. Tornino sulla Terra i vescovi Iannone e Arrieta [che hanno firmato la lettera di cui si parla, n.d.r.]: quel mondo di finzione finisce ai confini dello Stato della Città del Vaticano.
Roma sembra nutrire la convinzione radicata che l'unica parte che ha diritto alla buona fama sia il clero accusato. Questo non è vero. Anche la Chiesa ha dei diritti: il diritto di essere credibile nel chiedere conto al clero, i cui abusi sessuali provocano dileggio verso la Chiesa e il suo sacerdozio. E quando quell'abuso acquisisce le dimensioni che ha oggi, sembra che la misura di un motivo “legittimo e proporzionato” per parlare apertamente, sia stata colmata da tempo: la Chiesa ha anche il diritto e il dovere di essere trasparente in modo che i suoi figli e le sue figlie – soprattutto i figli e le figlie minorenni – possano sentirsi al sicuro in presenza di una persona che ha ricevuto gli Ordini sacri. Se non è la Chiesa ad occuparsi di questo diritto e dovere, lo farà l'autorità civile. E il rispetto di questo diritto e dovere non è solo un modo per evitare il coinvolgimento dell’autorità civile. L'autorità civile non può distogliere le risorse del pubblico ministero per condannare o scagionare persone morte (un tema chiave della lettera del Dicastero), ma questo non significa che la condanna o la discolpa debbano essere disattese, sospese all'infinito. Questo è il compito della Chiesa, sia per quanto riguarda gli accusati che erano suoi ministri, sia per quanto riguarda le presunte vittime che erano/sono suoi figli e figlie.
In una società normale, la maggior parte delle accuse prima o poi diventano pubbliche. La visione del Dicastero sembra che ciò sia una sorta di ingiustizia. Un'accusa non è una prova, ed ancor meno una condanna; ma non è nemmeno un nulla. L'accusa esiste. La mentalità di Roma sembra essere quella di far finta che non esista, fino a quando non sarà giudicata in modo completo e irreversibile. Questo non solo non è realistico, ma non è nemmeno un bene per la Chiesa, perché l'esperienza dimostra che questa mentalità rende possibile una cultura dell'insabbiamento. E, probabilmente, si può affermare che non è assolutamente richiesto dal punto di vista morale.
Senza dubbio questa mentalità di non dover riconoscere nulla finché non sia almeno canonicamente inevitabile e indiscutibile, serve a proteggersi dal dover spiegare cosa potrebbe accadere a Montefiolo e chi è coinvolto in questi fatti. Finché questa mentalità non verrà meno, il comportamento della Chiesa in materia di abusi sessuali e il suo occultamento saranno sospetti, e legittimamente. E se la Chiesa non risanerà i suoi atti legalmente, i suoi fedeli potranno costringerla a farlo affamandola finanziariamente. Colpire Roma nel portafoglio di solito ha un effetto salutare nel fissare la sua attenzione sull'essenziale. Ma non si dovrebbe diventare una “Chiesa povera dei poveri” per proteggere gli abusi.