AUTORI DEL '900/TESTORI
Lo scrittore scomodo che la scuola ignora
Il grande drammaturgo e romanziere cattolico milanese non compare nelle antologie scolastiche. Eppure le sue opere sono provocatoriamente attuali.
Culture
17_09_2011
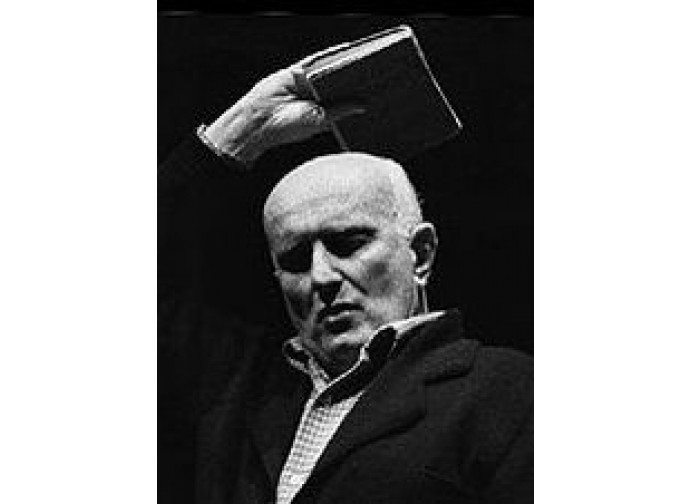
Poeta, drammaturgo, romanziere e pittore milanese, Giovanni Testori (1923-1993) è un autore scomodo, spesso escluso dalle antologie scolastiche sul Novecento. È giunto il momento di allargare quei ristretti canoni letterari che, talvolta, chiudono il secolo scorso con lo studio di Calvino e di Gadda, tralasciando, guarda caso, proprio grandi autori cattolici.
La sua produzione è sterminata e indice di grande versatilità nei diversi generi letterari, dal romanzo Il ponte della Ghisolfa (da cui Visconti ricava il film Rocco e i suoi fratelli) al ciclo di romanzi I segreti di Milano (ispirato ai cicli ottocenteschi francesi), dalle raccolte di poesie (L’amore e Per sempre) ai drammi teatrali che comprendono, ad esempio, rivisitazioni di Shakespeare (Ambleto, Macbetto) e la trilogia che consacra la conversione cattolica di Testori: Conversazione con la morte (scritta nel 1978 in seguito alla morte della madre), Interrogatorio a Maria (1979) e Factum est (1981). L’autore milanese affronta, spesso, nella sua vasta produzione anche temi di profonda attualità, che pochi hanno il coraggio di trattare, con un linguaggio forte, carnale e deliberatamente provocatorio.
Basti pensare ai drammi teatrali In exitu e Factum est. Nel primo è protagonista un lebbroso dell’epoca contemporanea, un drogato, in punto di morte, a Milano. Anche per lui, che ha venduto il proprio corpo, che ha distrutto la propria carne, anche per lui è possibile la rivelazione della verità. La verità è amore, è redenzione che abbraccia il tuo male e il tuo peccato. Ha un nome questa verità: è Cristo. Nei toni drammatici e quasi apocalittici della passione di un drogato, Gino Riboldi, si invera il mistero della resurrezione di Cristo che opera in questo mondo.
Invece, nel monologo teatrale, Factum est, strutturato in quattordici parti come se fosse una via crucis, Testori affronta una delle piaghe della contemporaneità: l’aborto. In fondo, per Testori, il dramma teatrale è sempre «un monologo a più voci» ed è «un’inchiesta sul destino dell’uomo: un destino che ha sempre come riferimento l’Essere Totale, cioè Dio». Nell’opera parla solo il feto, colui che nella realtà non ha diritto di parola, di espressione, di comunicazione della propria volontà. È lui che viene messo in croce, è lui il nuovo Cristo crocefisso, rifiutato, reso totalmente silente ancor prima che esca dal ventre della madre. In una dinamica antitetica a quella annunciata nel vangelo di Giovanni dove «verbum caro factum est» («il verbo si fece carne»), nell’opera la carne del feto (cui viene impedito di farsi carne al di fuori del ventre materno) si fa di volta in volta parola, profezia, maledizione. Il padre, però, non riconosce un senso, una causa e un fine a quel grumo di cellule: «Caso, bacio/ questo è stato». Il feto allora reagisce rivolgendosi alla madre: «Madre,/ mamma,/ a te m’aggrappo! […] Chi ti parla/ era pur come son io!». Il feto «chiede di venire alla luce e s’incarna nella sua stessa parola senza corpo. Nel grembo balbetta, strascica le parole, fino a che la voce si fa più percettibile, articolata, chiedendo una salvezza per sé e una speranza per la madre e per il padre che lo vogliono rifiutare». Nelle sue parole c’è un richiamo alla responsabilità del padre, quell’uomo che, anche se lo rifiuta, già è padre, perché il figlio è ormai concepito: «So, papà:/ io sono peso,/ peso vero;/ son fatica,/ son legame;/ da portare/ son legname;/ son catena;/ sono pena,/ ma,/ domani?/ Tu la vita,/ padre,/ ami?/ Forse un giorno/mi vedrai/ e dirai:/ «lasciar lui?/ Averlo mai?/ Mio bambino,/ vitellino,/ mio gattino…».
Una commozione ci riempie il cuore nel sentir parlare un essere così piccolo, innocente, che dapprima sembra insistere sull’affettività dei genitori, poi sul buon senso e sulla ragionevolezza, poi sembra implorare pietà, proprio come un condannato a morte. Infine, la sua voce si tramuta in maledizione e profezia di distruzione per chi osa perpetrare un tale abominio! Sono toni che ricordano la lauda drammatica «Donna de Paradiso» di Iacopone da Todi. Ivi, Cristo è imprigionato, sottoposto alla passione, crocefisso! Ancora lo Stabat mater di Iacopone è presente in quel «fa’ che arda,/ che la bruci […]. Fa’ che spada/ sia d’amore/ che trafigga/ in madre/ cuore». La Madonna rimase ai piedi della croce accanto al Figlio assassinato. Qui la madre diventa lei stessa omicida, degenere, lussuriosa. Non a caso Testori la apostrofa con un’allusione dantesca alla figura della lussuriosa Pasifae. Il feto demistifica tutte le moderne giustificazioni dell’aborto, presentato come manifesto del diritto e della libertà della donna, quando esclama: ««È per vivere/ - ti dici –/ Per avere libertà»./ Libertà/ di spegner vita?/ Libertà/ di violar Dio?/ Libertà per te/ è finita./ Che comincia/ è l’urlo eterno,/ primavera uccisa,/ inverno,/ sempre gelo,/ sempre brina./ Mai sarete/ come prima». Un destino di rovina attende quell’uomo e quella società che non riconosce la vita, che non l’abbraccia, dimentica del nulla che anche noi siamo stati e di quel Tutto che ci ha voluti e ci ha chiamato alla vita.
Un’altra opera teatrale di Testori, invece, ben documenta l’importanza della presenza di un maestro nella vita e, nel contempo, la drammaticità del rapporto tra l’allievo e il maestro. Si tratta de I promessi sposi alla prova, in cui Testori adotta la struttura del metateatro o teatro nel teatro tipica del pirandelliano Sei personaggi in cerca d’autore per rileggere il grande capolavoro di Manzoni. Testori, che ama particolarmente il capolavoro manzoniano, afferma che I promessi sposi sono «un romanzo della storia e il popolo incarna questa storia nella libertà più assoluta […]. Nella storia Dio non è una presenza che sovrasta i personaggi, ma che anzi li segue, li accompagna affinché ognuno, gli umili e i poveri come i potenti, arrivino ad un riconoscimento del senso e del significato». A partire dall’impostazione del dramma pirandelliano, anche Testori mette in scena sei personaggi (gli attori che interpretano Renzo e Don Rodrigo, le attrici che rivestono i panni di Lucia, Agnese, Perpetua, Gertrude) guidati da un regista/maestro, che incarnerà talvolta anche altre parti, in modo da non introdurre un settimo personaggio contraddicendo in tal modo l’impalcatura dei Sei personaggi.
L’azione teatrale si svolge in due giornate. All’inizio della prima il maestro insegna ai suoi allievi a recitare la propria parte. Li introduce, quindi, al proprio mestiere. Il proprio mestiere è come un compito che uno si assume nella vita, è una responsabilità nei confronti degli altri. Una sorta di missione. L’uomo ha, però, perduto il gusto di vivere, il gusto di essere uomo, di crescere e di scoprire la propria natura. All’inizio del primo atto, allora, il maestro decide di reimpostare il «problema della recita» con gli attori. Interviene in maniera esagerata, quasi ossessiva nella recita. Insegna ai ragazzi il valore della parola. Si fa nuovo Adamo che rinomina tutte le cose. Nominare la realtà significa conoscerla, quindi entrare in rapporto con lei e addentrarsi nelle sue profondità. Il maestro, fuori di metafora, introduce al reale. Chiaramente qui il discorso riprende l’evangelico «il verbo si fece carne» investendo poi ogni ambito dell’esistenza, invitando a recuperare un rapporto carnale e viscerale con la realtà, in un contesto culturale in cui pensiero e ideologia sembrano avere il sopravvento su tutto. La realtà nella sua concretezza educa, provoca, sollecita. Concretezza e carnalità caratterizzano l’espressività degli attori, che sempre più fanno proprie le direttive del maestro e iniziano a «testoreggiare», per usare le parole del testo, cioè a far diventare carne le parole, a renderle realtà, a far rivivere la storia. Così, anche quel pudico e casto amore dei due fidanzatini nei Promessi sposi si connota di fisicità, di desideri sopiti, di attese di soddisfazioni, pur conservando l’elevatezza che Manzoni le ha conferito. Bellissimo è il punto in cui Renzo afferma che quando ha incontrato l’amore, Lucia, ha capito perché è venuto al mondo. Siamo, infatti, nati per amare! Bellissime sono anche la semplicità e la concretezza con cui Agnese, Renzo, Lucia vivono il cristianesimo. Di fronte alle difficoltà, Agnese consiglia: «Invece di finir allagati dalle lacrime, diciamo su un rosario».
Un altro personaggio della storia, Gertrude, è considerato dal maestro il «pilastro nero» centrale, quello attorno al quale si può costruire un castello di menzogne. Perché Gertrude è così centrale, perché bisogna attraversare la sua figura per capire meglio il mistero dell’umano e della storia? Perché Gertrude è una vocazione abortita, una persona che non ha potuto aderire alla chiamata del Mistero con libertà. La sua persona è stata travolta anzitempo dalla violenza di chi pensava di usare il proprio potere per plasmare la coscienza altrui. Proprio per questo motivo Testori dedicherà a Gertrude un dramma teatrale intitolandolo La monaca di Monza.
Grande attenzione è rivolta, poi, al dramma che vive l’Innominato e alla sua conversione. Mirabile per profondità è il discorso in cui l’Innominato, guardando dentro di sé, sorprende la radice del proprio male e della propria azione: «Ci sono momenti, ore ci sono, in cui sembra essere stato il niente, proprio e solo lui, il niente, ciò che abbiamo corteggiato, desiderato ed amato; ciò per cui abbiamo, sempre, tutto osato. Allora – vedi?- anche una fogliolina che tremi lì, sull’albero, par troppo piena di vita e bisogna strapparla». Un abisso di niente si apre nel cuore dell’Innominato di fronte al male e al passato di iniquità. Lui osa guardarlo e starci di fronte, comprendendo che la sofferenza, il dolore, la malattia sono il prezzo del peccato, da offrirsi per l’espiazione. Così, l’Innominato esclama: «La paura, come la malattia e la morte, sono, teologicamente parlando, lo stipendium. Stipendium peccati, intendo. E io; io, sì, che per un momento urlo ancora come Innominato, quello stipendium, cioè quel prezzo, che è necessario, che bisogna – è inutile illuderci- bisogna- in un modo o nell’altro, pagare». La conversione dell’Innominato si apre alla speranza di una vita diversa e alla comprensione della sofferenza alla luce del mistero della croce di Cristo. Qui, è celata nella finzione artistica l’esperienza della stessa conversione di Testori.
Nella conclusione dell’opera teatrale il maestro si congeda dalla compagnia di attori auspicando che possano ora loro creare nuove compagnie, diventare a loro volta maestri. Se, poi, nella vita si incontreranno delle difficoltà, dolori, ansie, problemi, si dovrà battere sempre alla porta della speranza «con volontà, con forza, con amore». Parlando di questo testo teatrale, Testori si sofferma sulla figura del maestro che «scopre che insegnare, oggi, è ritornato necessario». Il maestro «non è qualcuno che opprime con il suo sapere; è, più cristianamente, qualcuno che consegna a dei giovani la propria esperienza e intanto si arricchisce della loro giovinezza. Un transfert religioso. […] Cerca di recuperarli al senso del loro mestiere, cioè, trattandosi di attori, alla loro umanità. Cerca di farli tornare uomini in quella «parola» che è il loro mestiere».
Questo è per noi il testamento spirituale di Testori: «Non sbaglierà, nonostante tutti gli errori, chi avrà voluto bene alla realtà, ossia alla creazione. Amando la realtà, ci sei dentro, ci vivi già dentro e abbracci il tuo tema, la vita, senza bisogno di astrazioni. Basta amare la realtà, sempre, in tutti i modi, anche nel modo precipitoso e approssimativo che è stato il mio. Ma amarla. Per il resto non ci sono precetti».




